
“Quando voglio sapere se una persona è nata povera non c’è niente di meglio che chiederle quante finestre c’erano nella casa in cui è cresciuta․”
Questo è l’incipit di un libro, “Seni e uova”*, scritto da una giovane giapponese, Mieko Kawakami․ Il critico d’arte contemporanea Francesco Bonami, in un suo podcast** dal titolo “Le finestre che raccontano il benessere”, commenta: “…questa frase dovrebbe essere una lettura obbligatoria per tutti gli architetti del mondo․” Si sa che gli architetti progettano case per il ceto ricco e benestante con numerose finestre, ampie vetrate che si affacciano su scorci gradevoli e rilassanti․ Di contro, nelle case per gli strati sociali più bassi le finestre rispondono soltanto a criteri di economicità e praticità, dunque poche e piccole․

Esiste su Facebook un gruppo che si chiama “View from my window”, “La Esiste su Facebook un gruppo che si chiama “View from my window”, “La vista dalla mia finestra” con oltre due milioni di iscritti․ Sono privati cittadini che si scambiano scene di vita casalinga e condividono ciò che vedono dalla loro finestra․ La maggioranza dei panorami mostrati sembrano foto di agenzie immobiliari che vogliono convincere a comprare quelle splendide case che permettono quelle splendide visuali da quelle ampie finestre․
Ma ci sono anche immagini di angoli di quartieri degradati e squallidi muri privi di intonaco, immagini che non lasciano dubbi sulla modestia e sulla povertà che incombe dietro quelle piccole finestre․
Ciò che si vede da una finestra ci dice molto di ciò che esiste dietro quella finestra․ La metafora “finestra sul mondo” ha dunque un’accezione ampia: non solo varco attraverso il quale guardiamo fuori, ma anche spiraglio che fa intravedere ciò che esiste dentro․ La finestra come metafora è di vecchia data․ La pittura, la fotografia, il cinema hanno da sempre usato tale immagine abbondantemente, sfruttando l’ambiguità dell’oggetto che può sia aprire che chiudere, sia mostrare che celare․
Nel periodo critico della pandemia da Covid il lockdown ha obbligato le persone a rinchiudersi in casa․ Le finestre e i balconi, insieme al web, hanno in parte permesso in qualche modo il mantenimento della relazione sociale․
Nei racconti che sono seguiti al duro periodo del lockdown si capiva quanto la disponibilità di ampie finestre o balconi abbia influito sul diverso grado di stress patito․ E di questa situazione se ne poteva avere un’immagine plastica nelle immagini serali delle finestre․ Le ampie finestre illuminate e gli ariosi balconi “arredati” erano la luminosa testimonianza di una resilienza ben organizzata, mentre le striminzite finestre delle case popolari che potevano far filtrare ben poca illuminazione sembravano boccheggiare alla ricerca di aria e libertà․ E non era difficile intuire le diverse difficoltà nella gestione del famigerato smartworking: si lavora meglio in smartworking nel silenzio di un bel salone con una bella vetrata o seduto, magari a turno con altri famigliari, ad un tavolo con la bella vista, quando va bene, del palazzone di fronte?

Come non concordare con Bonami quando al termine del suo podcast dice: ”…Non c’è da meravigliarsi se la gente, molto spesso non ricca, si rifugi dentro la finestra dei social․ È sempre meglio, in fondo, che guardare un muro”․
*Seni e uova – Mieko Kawakami – Edizioni Eo
** “Le finestre che raccontano il benessere”, podcast di Francesco Bonami, quotidiano “La Repubblica” del 20 settembre 2020
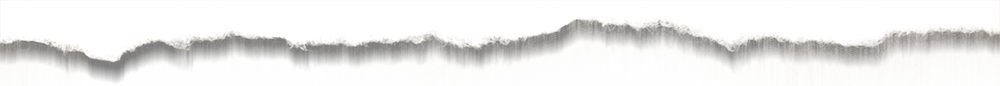

Attività
PREPOSIZIONI
Livello avanzato
CLICCA QUI per scaricare e stampare l’attività relativa all’articolo







